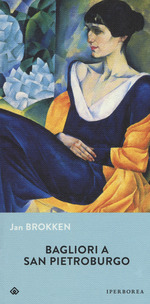Parla con Gariwo Nadav Tamir, l’ex consigliere personale di Shimon Peres
Nadav Tamir, diplomatico israeliano, è il direttore esecutivo di J-Street in Israele: J-Street è un’organizzazione ebraico-americana che lavora per promuovere la politica estera americana pro-Israele e pro-pace. Nadav Tamir è anche serior advisor per gli affari governativi e internazionali al Peres Center for Peace and Innovation, ex consigliere personale di Shimon Peres per gli affari diplomatici, membro del comitato direttivo dell’Iniziativa di Ginevra e del think-tank Mitvim. Ha lavorato all’ambasciata di Israele a Washington e come console generale nel New England. In questa intervista sul conflitto israelo-palestinese, ci parla delle realtà esistenti di collaborazione tra arabi ed ebrei, del ruolo della comunità internazionale, e dell’estremismo e della leadership moderata sia in Israele che in Palestina.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un disperato appello di pace da Neve Shalom, un villaggio in Israele dove arabi palestinesi ed ebrei israeliani vivono insieme, praticando la non violenza e la coesistenza pacifica. Può dirci di più sulle realtà esistenti di collaborazione tra ebrei e arabi?
Ci sono tanti progetti di collaborazione tra ebrei e arabi: secondo me questo è l’unico motivo per cui essere ottimisti nel mezzo di questo disastro. La maggior parte della gente vuole vivere in pace, anche se gli estremisti ricevono sempre molta più attenzione. Oggi molte di queste realtà di collaborazione sono ben collegate attraverso i social media, e c’è persino un gruppo Whatsapp con tutte le diverse iniziative che riuniscono arabi ed ebrei. Una delle più interessanti è Women Wage Peace, un’organizzazione guidata da donne, sia arabe che ebree, sia di destra che di sinistra, sia religiose che laiche, che sono unite nella richiesta di un accordo non violento reciprocamente vincolante tra israeliani e palestinesi, e che credono anche che le donne debbano essere più coinvolte nel processo decisionale, un punto di vista che condivido. Ma ci sono tante altre reti professionali e politiche diverse, di diversa provenienza: medici, comuni, ONG e organizzazioni no-profit, artisti: c’è di tutto.
Molti di questi gruppi hanno manifestato molto in questi giorni, chiedendo la cessazione delle violenze. Pensa che queste istanze possano trovare un spazio in politica?
Sì, penso di sì. Uno dei motivi per cui Netanyahu non è riuscito ad ottenere la maggioranza nelle ultime elezioni è stato a causa delle proteste civili, enormi in Israele negli ultimi due anni. La gente vi ha preso parte per motivi diversi. Per me, si trattava soprattutto del conflitto israelo-palestinese; per altri, della corruzione o dell’erosione della democrazia. In generale, comunque, quelle proteste hanno dato voce a un’insoddisfazione diffusa tra gli israeliani riguardo alla politica attuale. Tutto questo ha colpito anche la destra israeliana. New Hope – il recente partito di centro-destra fondato da Gideon Sa’ar – è nato proprio da una grande insoddisfazione per la politica di Netanyahu da parte di persone che credono che si possa essere di destra senza essere populisti, senza mettere se stessi prima del paese, e senza essere corrotti.
Dove sono ora queste voci critiche?
Quando il popolo israeliano è sotto attacco, molti si attaccano alla bandiera e scivolano in un sostegno poco critico del governo, prendendo sul personale ogni critica alle nostre politiche. Per questo stesso motivo mi capita di discutere anche all’interno della mia famiglia: è come se la gente non riuscisse a distinguere tra le politiche del governo e lo stato di Israele. La mettono in questi termini: o sei per Hamas, o sei per Israele. Ma non è questo il punto: per me, Hamas è un’organizzazione terroristica, ma questo non esime Israele dalle sue responsabilità per non aver creato un vero processo di pace e aver fatto uno sforzo reale, anche all’interno di Israele, per trattare con rispetto e uguaglianza gli arabi israeliani. Spero davvero che, ora che è stata concordata una tregua, il popolo israeliano sia più aperto a riflettere sugli errori e sulla mancanza di strategia che ci hanno portato a questa situazione.
In un recente articolo, lei ha detto che la “Legge sullo stato-nazione” – che il governo di Netanyahu ha approvato nel 2018 – ha inviato un chiaro messaggio agli arabi israeliani definendoli cittadini di seconda classe. Potrebbe dirci qualcosa di più su questa legge? Perché Israele ce l’ha e da dove viene?
Prima di tutto, è fondamentale chiarire che Israele non ha una costituzione scritta. Quando Ben Gurion dichiarò l’indipendenza di Israele, pensò che fare i conti con questioni giudiziarie sarebbe stato troppo complicato e avrebbe rappresentato una minaccia esistenziale per Israele. Così, decise di adottare il modello britannico, caratterizzato dall’assenza di una costituzione. Ma la Gran Bretagna e Israele sono molto diversi. La Gran Bretagna ha una lunga tradizione democratica di precedenti che assicurano la protezione e la salvaguardia dei diritti umani, e questo non è il caso di Israele. Nel nostro paese, molti vedono la Dichiarazione d’Indipendenza come una Costituzione. Credono, per esempio, nel principio della Dichiarazione secondo cui Israele è una patria sia per il popolo ebraico che per i suoi cittadini di altre confessioni religiose, un paese basato sulla libertà, la giustizia e la pace, in cui la completa uguaglianza dei diritti sociali e politici è assicurata a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di religione, razza o sesso. Ma altre persone non considerano questi principi come valori fondanti in Israele, e questo è all’origine di un eterno conflitto tra la sinistra e la destra. Molte persone di destra dicono che la nostra corte suprema è troppo universale, troppo liberale, e si lamentano perché manca un carattere distintamente ebraico nelle leggi dello Stato. Per me, queste obiezioni non hanno senso: come ebreo, credo che la democrazia sia di per sé un valore ebraico perché è l’ebraismo che ha portato nel mondo l’idea che siamo tutti uguali. Eppure, la destra israeliana ha alla fine approvato una legge che dà al carattere ebraico dello Stato uno statuto prevalente sul valore liberale della democrazia, promuovendo così ineguaglianza e discriminazione. Questa legge, per esempio, sancisce l’ebraico come lingua ufficiale di Israele, declassando l’arabo – la lingua parlata dagli arabi israeliani – a uno “status speciale”. Ci sono persone nel centro e a sinistra che vogliono aggiungere uguaglianza a questa legge in modo che gli arabi, anch’essi cittadini d’Israele, non siano trattati in modo diverso degli ebrei. Per me, tutto questo è ancora più sorprendente perché noi stessi siamo stati una minoranza in altri paesi. A causa di ciò che abbiamo sofferto, dovremmo essere un modello sul trattamento delle minoranze. L’idea stessa di avere un nostro Stato è stata pensata come un modo per riparare a ciò che abbiamo sofferto.
Oggi potremmo sostenere che Hamas è il vero vincitore di questa guerra, perché, come lei ha scritto, Hamas ha riempito un vuoto creato dal governo israeliano e dall’Autorità Palestinese, presentandosi ora come il vero difensore degli arabi, in Israele come in Palestina.
Sì, assolutamente: Hamas vincerà questa guerra, al di là di quante persone verranno uccise, perché ha dimostrato ai palestinesi in Cisgiordania e ai palestinesi in Israele che è Hamas a prendersi cura degli arabi e dei musulmani. Gli altri vincitori di questa guerra saranno gli israeliani, come Netanyahu e i suoi sostenitori, che si rifiutano di raggiungere un accordo e un compromesso con i palestinesi. Ogni vittoria di Hamas è anche una vittoria anche per loro. I palestinesi moderati, invece, saranno i più colpiti. Anche se hanno le loro colpe, penso che l’unica via d’uscita da questo conflitto sia il rafforzamento dei palestinesi moderati, che non credono nel terrorismo o nella violenza come mezzo per realizzare gli interessi dei palestinesi. Con la sua politica, Israele li sta rendendo sempre più deboli.
In che modo, in particolare, pensa che Netanyahu sia responsabile di aver rafforzato Hamas?
Rifiutandosi di trattare diplomaticamente la questione palestinese e manipolando la paura e i traumi degli ebrei. Mantenere Gaza e la Cisgiordania separate, permettere al denaro del Qatar di sostenere Hamas e, allo stesso tempo, rispondere solo militarmente ai loro attacchi senza alcuna strategia: tutto questo mantiene Hamas in vita non solo fisicamente ma concettualmente. Questo conflitto ne è stato il miglior esempio. Avevamo quasi raggiunto una coalizione di cambiamento che potesse rimuovere Netanyahu dal suo ruolo, ma questa violenza ha provocato molta pressione sui membri di questa coalizione. Nella politica israeliana, la violenza gioca sempre a favore di Netanyahu, che alimenta la paura e fa leva sui traumi che il popolo ebraico ha subito nella storia. È per questo che Netanyahu rende l’Iran molto più grande di quello che è; è per questo che rende il movimento BDS molto più grande di quello che è; è per questo che rende l’antisemitismo molto più grande di quello che è. Per Netanyahu, la paura è l’unico strumento per restare al potere: ma i fondatori di Israele volevano ispirarci con la speranza, un principio che Netanyahu continua a trascurare.
E l’amministrazione americana? Il conflitto israelo-palestinese non era esattamente in cima all’agenda di Biden. Lui ha espresso il suo sostegno a Netanyahu, ma i democratici sono sempre più divisi su questo tema. Cosa pensa che possano fare gli Stati Uniti?
Biden è un amico di Israele. Eppure, nei suoi anni da vicepresidente durante il mandato di Obama ha capito che il conflitto israelo-palestinese è una questione radioattiva nella politica americana. Biden non voleva entrare troppo presto in questa questione: preferiva occuparsi prima di cose che sapeva già come gestire. Sperava che in Israele e il Palestina le cose rimanessero relativamente quiete per un po’, dato il caos politico in cui si trovavano entrambi i paesi. Biden ha bisogno di tempo per invertire alcune delle cose più dannose fatte da Trump. Ma il conflitto israelo-palestinese non è qualcosa che si può trascurare, in un modo o nell’altro alla fine bussa alla porta. Adesso Biden sta usando i vecchi argomenti perché non ha ancora elaborato una sua strategia rispetto a questo problema: non ha neanche nominato un ambasciatore per Israele. Ma ora il conflitto è diventato un fattore ineludibile, e c’è pressione perché lui faccia qualcosa. Spero davvero che Biden affronterà questa questione in modo adeguato, nominando qualcuno che se ne occupi se non ha il tempo di farlo lui stesso.
L’anno scorso, l’ex presidente americano Trump ha promosso i cosiddetti accordi di Abramo tra Israele e quattro stati arabi, descrivendoli come “l’alba di un nuovo Medio Oriente”. In realtà, quegli accordi hanno portato a una perdita di interesse, da parte dei paesi arabi vicini a Israele, nel sostenere la Palestina. Questo ha favorito Netanyahu nel suo ignorare la questione palestinese. Secondo lei come hanno agito e come agiranno questi accordi sul conflitto?
L’intenzione iniziale di Trump e Netanyahu non era di firmare gli accordi di Abramo, ma di promuovere l’annessione di parti significative della Cisgiordania a Israele. Quando hanno saputo che gli arabi non avrebbero mai accettato questo piano, Trump e Netanyahu hanno deciso di ripiegare sul piano B, giocando sugli interessi economici degli arabi e proponendo così gli accordi di Abramo. Penso, comunque, che il processo di normalizzazione potrà aiutare i palestinesi nel lungo periodo. Ma questo è possibile solo se Biden riesce a includere i palestinesi in questo processo, permettendo loro di beneficiare dei suoi vantaggi. In questo caso, la normalizzazione potrebbe trasformarsi in un potente strumento per porre fine a questo conflitto. Anni fa, Shimon Peres parlava di un “nuovo Medio Oriente” perché credeva che un approccio regionale potesse portare benefici anche ai palestinesi. Ma questo accadrà se i palestinesi saranno inclusi, e non solo scavalcati, nel processo di normalizzazione.
Pensa che Biden revocherà questi accordi, allora? E che farà lo stesso con spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme da parte di Trump?
Non credo che Biden revocherà gli accordi di Abramo, né il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme. È abbastanza chiaro che la capitale di Israele è Gerusalemme: il grande errore è stato ignorare l’aspirazione palestinese a una propria capitale. Quello che Trump avrebbe dovuto fare era, sì, spostare l’ambasciata a Gerusalemme, ma dichiarare che voleva anche un’ambasciata a Gerusalemme Est, nella capitale palestinese. Questo potrebbe farlo Biden.
Alcuni ritengono che le azioni di Hamas siano orchestrate dall’Iran. Altri sostengono che Hamas stia agendo autonomamente, con dinamiche interne più che internazionali. Lei cosa ne pensa?
A molte persone piace spiegare le cose come parte di una grande cospirazione. Le cose sono molto più semplici di così. Prima di tutto, Hamas e l’Iran sono molto diversi. L’Iran, per esempio, è un paese sciita guidato da sciiti che vogliono esportare la rivoluzione sciita iraniana in altri paesi, mentre non ci sono sciiti tra i palestinesi. Naturalmente esistono alcuni interessi comuni: sia l’Iran che Hamas vogliono combattere Israele, entrambi sono antiamericani e antioccidentali. Possono anche verificarsi degli eventi sporadici, come il recente drone iraniano al confine con la Giordania, ma credo che gli ultimi eventi siano stati molto più locali e sicuramente non architettati dall’Iran, che ora è occupato con le elezioni e non è interessato alla questione palestinese.
Uno degli aspetti più sorprendenti di questo conflitto è stata l’esplosione di violenza tra ebrei israeliani e arabi israeliani, anche in zone dove la coesistenza era stata pacifica per molto tempo. Quali conseguenze avranno questi scontri in futuro?
Penso che questo debba essere un campanello d’allarme per Israele rispetto a come trattare le sue minoranze arabe. Israele dovrà trattare la sua popolazione araba in modo più serio ed equo, per non lasciare che gli estremisti si impadroniscano della situazione. Ma questo dipende molto dalla futura leadership israeliana. Se Netanyahu e i suoi amici fascisti guideranno il paese, non ci sarà alcun miglioramento, e le cose potranno solo peggiorare.
Parliamo allora di leadership. Secondo lei cosa comporterà questo conflitto nela leadership israeliana?
È molto difficile prevedere il futuro: ci sono molte nuove dinamiche in atto, e le cose sono molto meno lineari di prima. Lo scenario più probabile è che Israele organizzerà le elezioni per la quinta volta e che la frangia estremista e razzista della politica israeliana guadagnerà molto potere, anche grazie al contributo di partiti di destra che prima erano più collaborativi con la sinistra. Tuttavia, spero anche che la sinistra esca più forte da questa crisi: nel centro-sinistra, per esempio, Yahir Lapid ha guadagnato molta saggezza e ha imparato a fare politica. Spero davvero che riesca a formare una coalizione contro Netanyahu e i partiti ultraortodossi.
E la leadership palestinese?
Il cambiamento arriverà, prima o poi. Spero che le forze moderate riescano a formare una leadership congiunta: finchè saranno divise, questo giocherà a favore di Hamas. Inoltre molto dipende da noi, da Israele, dagli Stati Uniti, dall’Europa, dalla comunità internazionale. Se aiuteremo nelle negoziazioni, se aiuteremo a raggiungere un qualche orizzonte di pace, questo rafforzerà i moderati. Se continuiamo a trascurare questo conflitto, non cambierà nulla. Il conflitto israelo-palestinese è come andare in bicicletta: se non si va avanti, si cade. È fondamentale che la comunità internazionale sostenga gli elementi più moderati della politica palestinese e sia d’aiuto: non dico trovando una soluzione a tutto, ma almeno aiutando nelle negoziazioni.
Come recuperare la prospettiva della soluzione dei due stati? Chi saranno i soggetti del cambiamento? Cosa deve fare Israele? In un recente articolo, lei ha scritto che “il governo israeliano deve dar forma a una politica completa per la questione palestinese, incentrata sulla diplomazia strategica con la leadership palestinese dedicata a trovare una soluzione al conflitto e che ci liberi da schemi futili e ripetitivi”. Ci può dire, più nel dettaglio, in cosa consiste questa politica?
Prima di tutto dobbiamo renderci conto che non esistono soluzioni militari a questo conflitto: anche l’esercito più forte del Medio Oriente – il nostro, che sta diventando sempre più forte – non risolverà nulla. I governi israeliani usano troppo spesso le Forze di Difesa Israeliane, ma questa non è la via d’uscita da questo conflitto. Hamas non scomparirà, anche se continuiamo a bombardarli. L’unico modo per sconfiggere Hamas è cominciare a negoziare con i palestinesi moderati – e non solo per il gusto di negoziare e per ottenere una certa legittimità internazionale, ma con delle negoziazioni che cerchino veramente di raggiungere la soluzione dei due stati. La soluzione esiste: abbiamo bisogno di una leadership moderata da entrambe le parti per attuarla. Shimon Peres diceva che, nel conflitto israelo-palestinese, abbiamo la luce e ci serve il tunnel. L’accordo è abbastanza chiaro, ed è scritto negli accordi dell’iniziativa di Ginevra del 2003:
- tornare ai confini precedenti al 1967
- avere una capitale palestinese a Gerusalemme Est con accordi speciali nella zona dei luoghi sacri, tramite cui tutte le religioni possano essere rispettate e si possa stabilire una forma di sovranità comune
- affrontare la crisi dei rifugiati palestinesi
- avere accordi di sicurezza regionale che coinvolgano altri paesi che vogliono stabilità.
La soluzione è lì, scritta sulla carta. Abbiamo solo bisogno della volontà politica di raggiungerla. E nell’era di Netanyahu, non abbiamo questa volontà politica. La maggioranza della gente sostiene la soluzione dei due stati. Una volta che ci sarà la leadership per andarci, avremo il sostegno del pubblico.
Qual è il ruolo di J-Street in questa fase?
J-Street è stata creata perché molti ebrei liberali e progressisti in America si sentivano poco rappresentati dalle maggiori e più note organizzazioni ebraiche. Da un lato J-Street è nata per accogliere persone pro-Israele e pro-pace. Dall’altro il nostro obiettivo è avere un impatto politico. Siamo un’organizzazione di advocacy e lobbying che cerca di influenzare la politica americana in Medio Oriente con valori di pace e diplomazia. Stiamo cercando di convincere l’amministrazione Biden ad essere più attiva e, nella sezione israeliana, stiamo lavorando per rafforzare la diplomazia israeliana orientata alla pace. J-Street si trova a metà tra la comunità ebraica e il partito democratico. Noi non pensiamo che Israele abbia sempre torto, così come non pensiamo che Israele abbia sempre ragione. Pensiamo che Israele debba imparare dai suoi errori e che l’America debba sostenere la pace e non la violenza. Crediamo che questa sia anche l’intenzione di Biden, ma gli manca lo spazio politico per agire in questo senso. Noi creeremo quello spazio politico.
Vuole mandare un messaggio a chi ci legge?
Il mio messaggio a tutte le persone che leggono questa intervista è: abbandonate lo scaricabarile e cercate un dialogo costruttivo. Abbiamo bisogno di un approccio comune alla soluzione dei problemi, in cui sia gli israeliani che i palestinesi possano unirsi per andare avanti. Per J-Street, questo significa fare pressione sulla politica americana. Per i paesi europei, questo significa rafforzare l’Unione Europea perché possa sostenere e fare pressione su Israele al tempo stesso. Se si fa solamente pressione, Israele si rifugerà – come sempre, purtroppo – nella retorica dell’antisemitismo. Con un incondizionato sostegno, invece Israele vi sarà per scontati. Fare entrambe le cose è la cosa giusta.
21 maggio 2021