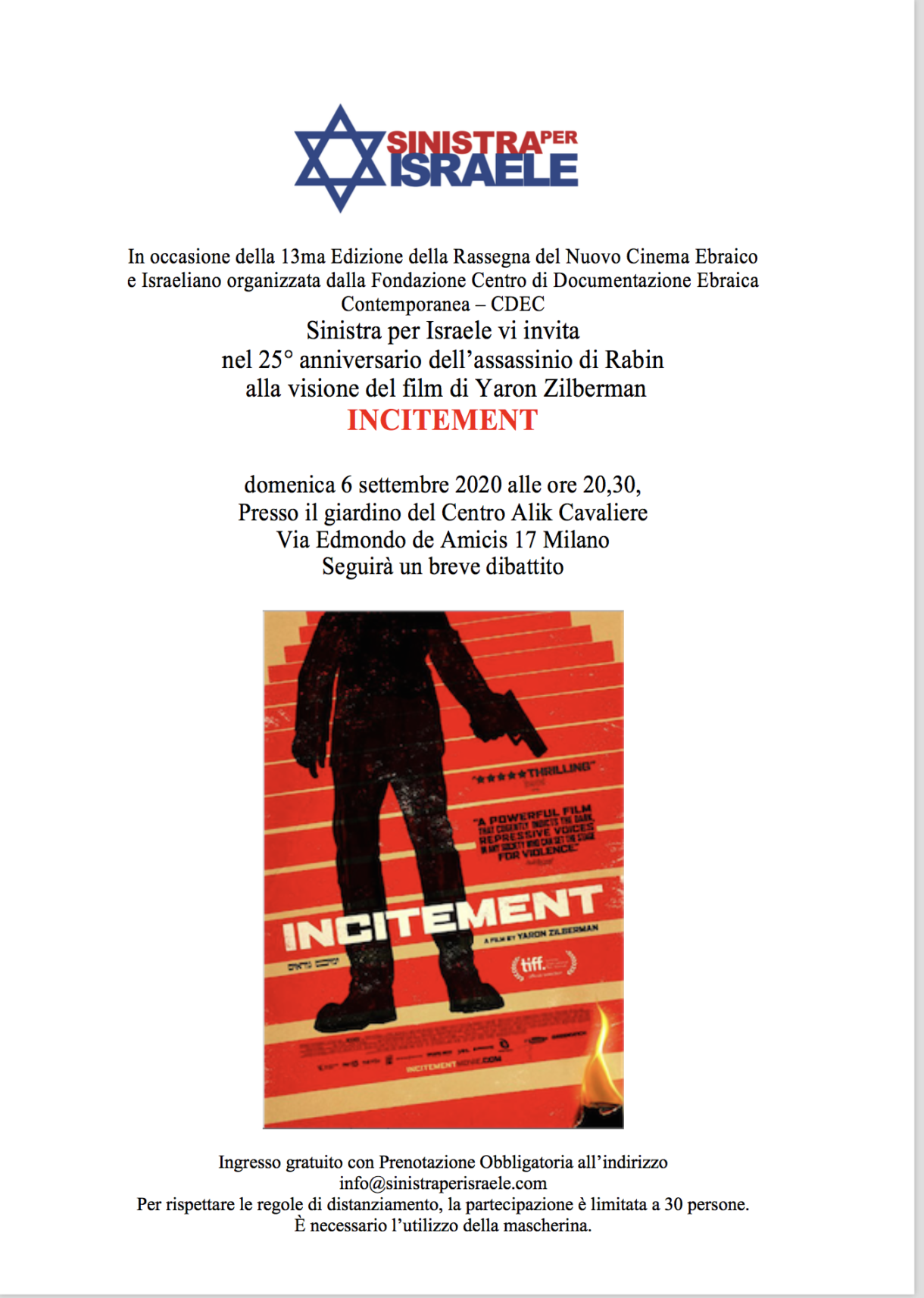Israele: la crisi della sinistra
Giorgio Gomel – La Stampa Giovedì 24 Settembre 2020
Dopo una campagna virulenta e segnata, come nelle precedenti elezioni dell’aprile e settembre 2019, dall’isterismo ossessivo agitato dai partiti di destra contro gli arabi israeliani – circa il 20% dell’elettorato – i risultati del voto del 2 marzo scorso confermano il senso di un paese fortemente diviso, polarizzato sugli estremi. Netanyahu, giunto alla sua ottava campagna elettorale come leader del Likud e premier con ininterrotta continuità da undici anni, ha improntato la campagna a un plebiscito sul suo conto nell’imminenza del processo che lo attende per casi di corruzione, frode e abuso d’ufficio. Il processo, che sarebbe dovuto iniziare il 17 marzo, è stato rinviato, su decisione del ministro della Giustizia uscente da lui stesso recentemente nominato, prima alla seconda metà di maggio, poi a luglio, infine a dicembre prossimo, in ragione del diffondersi anche in Israele dell’epidemia da Coronavirus. I temi dirimenti per il futuro del paese – un accordo di pace con i palestinesi e il mondo arabo, il rispetto dello Stato di diritto e delle prassi democratiche, il legame controverso fra religione e politica, il monopolio del rabbinato ortodosso in materia di diritto civile e di famiglia, l’acuirsi delle diseguaglianze socioeconomiche – sono stati largamente elusi.
Il premier uscente ha colorato il confronto elettorale di una forte impronta ideologica: da un lato rilanciando la campagna d’opinione rivolta a delegittimare le istituzioni indipendenti e subordinare il potere giudiziario, in particolare la Corte suprema, a Parlamento e governo; dall’altro invocando l’annessione della Valle del Giordano e l’estensione anche formale della sovranità di Israele sugli insediamenti nei Territori palestinesi, rifacendosi al piano di pace dell’Amministrazione Trump. La coalizione uscente – composta dal Likud come centro di gravità e da altri partiti religiosi e della destra nazionalista – è rimasta però al di sotto della soglia maggioritaria (59 seggi contro 61). All’opposizione la sinistra ebraica, unitasi con l’alleanza fra il Partito laburista, più attento alle istanze socioeconomiche – il degrado del welfare state, l’acuirsi delle disparità di reddito – e il Meretz, unico a sostenere con forza il diritto dei palestinesi a uno Stato e a difendere la democrazia incompiuta del paese, ha subito un’ulteriore flessione al 5% circa dei suffragi, soffrendo in parte dello slittamento del voto “utile” verso il partito di centro Blu e bianco. Solo la sinistra, con i partiti arabi, ha sollevato con forza il dilemma del futuro democratico del paese. Una democrazia limitata a causa: a) della legge sullo “Stato-nazione ebraico” che codifica una condizione di diseguaglianza fra ebrei e arabi cittadini di Israele; i secondi godono di pari diritti individuali, civili e politici, ma non dei diritti collettivi di minoranza nazionale; b) del clima ossessivo volto non solo a delegittimare il potere giudiziario, ma anche a demonizzare l’accademia, la stampa, le ONG attive nella difesa dei diritti umani, avvicinando Israele a paesi retti da partiti nazional-populisti.
La Lista araba unita ha ottenuto un ulteriore corposo successo giungendo a 15 seggi: vi hanno influito la crescente partecipazione al voto dei cittadini arabi di Israele; la loro volontà di incidere in misura maggiore sul corso politico del paese in parallelo al processo di integrazione economica e civile nella società israeliana; infine, la stessa disponibilità manifestata dalla leadership dei partiti unitisi nella Lista a sostenere un governo di centrosinistra qualora fosse annullata la legge dello “Stato-nazione ebraico”, ripresi i negoziati con l’Autorità palestinese e promosso con più vigore il progresso delle comunità arabe di Israele, che soffrono di arretratezza, povertà e crimine. Alcuni analisti dei flussi elettorali hanno sottolineato che circa 20.000 elettori ebrei hanno spostato il loro voto dai partiti classici della sinistra ebraica alla Lista araba.
La novità dirimente post elezioni sarebbe stata l’ipotesi di un appoggio esterno in Parlamento da parte della Lista araba a un governo guidato da Benny Gantz, il leader del partito centrista. Lo stesso Gantz aveva rigettato in verità come provocatoria l’offerta di appoggio della Lista araba nel corso della campagna elettorale, volendosi “coprire a destra” e cedendo alle seduzioni dell’isteria antiaraba. Uno sviluppo siffatto avrebbe rappresentato la rimozione di un tabù paralizzante per il sistema politico del paese sin dalle origini: soltanto il governo guidato da Yitzhak Rabin fra il 1992 e il 1995 si avvalse infatti del sostegno dei partiti arabi, che fu rilevante nelle trattative che condussero agli accordi di pace di Oslo fra israeliani e palestinesi.
Ciò non è avvenuto. La coalizione sarebbe stata in verità assai eterogenea, composta, oltreché dal suo partito, dalla sinistra ebraica e dal partito Yisrael Beiteinu, guidato da Lieberman, alfiere degli ebrei russi immigrati in Israele, nazionalista di destra e di impronta fortemente laica, oppositore accanito del peso coercitivo delle autorità e dei partiti religiosi sulla vita civile del paese. Il governo di unità nazionale che si è poi formato dopo una lunga crisi istituzionale raggruppa intorno al Likud e ai partiti religiosi una parte del partito di Gantz che ha subito una scissione e i residui del Partito laburista, ridottosi a 3 seggi.
Al di là dei fatti contingenti, è in atto da tempo uno spostamento profondo e permanente della società israeliana verso posizioni etno-nazionaliste. Nelle inchieste d’opinione oltre il 50% degli intervistati si dichiara di destra, contro il 25% di centro e meno del 15% di sinistra, un orientamento prevalente soprattutto fra i giovani. Fenomeno dovuto alle trasformazioni sociali e demografiche del paese: la grande immigrazione dalla Russia postsovietica dei primi anni Novanta (circa 800.000 persone); il prevalere di una visione del mondo etnocentrica, che combina in molti casi rigorismo religioso e chiusura nazionalista, fra molti dei 600.000 immigrati giunti in Israele negli ultimi venti anni da Russia, Ucraina, Francia, Stati Uniti; il crescere del peso demografico ed elettorale dei religiosi, circa il 15% del paese.
Vi è qualcosa di paradossale, quasi una scissione fra preferenze dei cittadini e comportamenti nel voto. Nelle inchieste d’opinione gli israeliani mostrano di condividere le posizioni della sinistra non solo in materia di diritti civili e sociali o di ruolo dello Stato in settori quali la sanità e l’istruzione, ma anche sul conflitto israelo-palestinese. Tuttavia le preferenze “rivelate” nel voto premiano la destra, in modo coerente e continuo ormai dal 2009, quando con le dimissioni di Olmert, imputato di corruzione, il suo partito centrista Kadima capeggiato dalla Livni, pur vittorioso nelle elezioni, non riuscì a formare una coalizione di governo. Da allora la premiership è nelle mani di Netanyahu. La debolezza della sinistra è anche una conseguenza nefasta della strada nichilista imboccata dai palestinesi: l’esplodere della violenza terroristica contro civili israeliani negli anni 2001-05, la guerra di guerriglia mossa da Hamas dalla Striscia di Gaza, il rigetto da parte di Abu Mazen delle offerte positive del governo Olmert-Livni nei negoziati del 2008.
La sconfitta della sinistra ebraica è eclatante anche nella retrospettiva storica. Quella sinistra socialdemocratica fondatrice dello Stato, anzi delle prime istituzioni pre-Stato (la Histadrut, il sindacato operaio, i kibbutzim), che ha retto il paese nei suoi primi trenta anni fino alla vittoria del Likud di Begin nel 1977 e che ancora nel 1992, guidata da Rabin, ottenne il 47% dei suffragi (56 seggi su 120), è oggi ridotta al 5% (7 seggi).

La divisione fra destra e sinistra nella storia politica di Israele concerneva tipicamente tre questioni: a) il welfare state e l’intervento pubblico nella sfera economica; b) il rapporto fra religione e Stato; c) il conflitto con i palestinesi. La frattura fra i due schieramenti negli ultimi dieci anni ha investito anche il tema del rispetto dello Stato di diritto e delle norme di una democrazia liberale minacciata dalle pulsioni autoritarie dei partiti di destra.
Due gli elementi determinanti del regresso dei partiti di sinistra. Il primo, forse preminente, attiene all’identità affermatasi via via dagli anni Novanta fra la sinistra e il “campo della pace” – partiti, movimenti, organizzazioni della società civile attivi nel promuovere prima la trattativa fra Israele e l’OLP, poi l’attuazione degli accordi di Oslo e una composizione negoziata del conflitto basata sul principio di “due Stati per due popoli”. Il fallimento di questo disegno nei negoziati di Camp David (2000) e Annapolis (2008), lo scetticismo circa la fattibilità della soluzione “a due Stati” – ritenuta ancora con favore dal maggior numero di israeliani, ma percepita come non più possibile – si è riflesso pesantemente sulle sorti politiche della sinistra, vista come incapace di guidare il paese, garantirne la sicurezza e gestire, se non risolvere, il conflitto. Meglio allora conservare lo status quo, un regime di occupazione di parti rilevanti della Cisgiordania e il blocco rigido della Striscia di Gaza: un’occupazione che persiste da oltre cinquant’anni, corrompe occupanti e occupati, ma protegge gli israeliani dal rischio di una pace vissuta come qualcosa di distante, velleitario o utopico. Non sono solo infatti gli oltre 400.000 israeliani che vivono negli insediamenti in Cisgiordania a rendere la soluzione di “due Stati per due popoli”, con uno Stato palestinese indipendente che riconosca la legittima esistenza di Israele e stabilisca con esso rapporti di buon vicinato, sempre più difficile sul terreno. Una vasta parte della società israeliana preferisce i palestinesi “invisibili” dietro il muro di separazione eretto lungo la Linea verde e per lunghi tratti assai più a est in Cisgiordania.
Su tale esito ha agito la retorica scatenata da partiti, opinion makers e media vicini alla destra e dediti a dipingere il movimento per la pace come visionario, utopista o, peggio, traditore. Smolanit, in ebraico “di sinistra”, è diventato nel lessico politico-popolare in Israele quasi un insulto, l’immagine di gente antipatriottica disposta a sacrificare le ragioni della sicurezza dello Stato per rincorrere astratti ideali.
Il secondo elemento attiene al tema delle identità in senso etnico e socioculturale. Il Likud, già dalla vittoria elettorale del 1977, ha teso a rappresentare la sinistra come espressione dell’élite di origine europea – ashkenazita più specificamente – che ha dato vita al paese e alle sue istituzioni, lo ha dominato per anni sul piano economico, sociale e politico e tuttora esclude gli ebrei di origine “orientale” dal potere effettivo. Di qui un sentimento di frustrazione rabbiosa di molti elettori di quella parte del paese che si riversa contro la sinistra. Nonostante il tentativo del Partito laburista in anni recenti di ritornare alle sue fondamenta socialdemocratiche, enfatizzando la questione delle diseguaglianze di reddito e coltivando gli interessi degli strati emarginati della società e delle aree arretrate del paese dove sono più numerosi ebrei immigrati dai paesi arabo-islamici, l’esito sul piano elettorale è stato deludente.
L’unico modo per una riscossa del centrosinistra è forse un’intesa con la minoranza araba nel paese, un’alleanza anche politica per costruire una società fondata su principi di eguaglianza e democrazia, in base alla quale i partiti ebraici si battano per modificare la legge dello Stato-nazione e includere gli arabi nel body politico del paese alla pari e gli arabi accettino Israele come Stato democratico a maggioranza ebraica.