
La pandemia dell’antisemitismo, le mutazioni dell’antisionismo
Gabriele Eschenazi Gariwo 12 maggio 2020
Cartelli con svastiche, accuse agli ebrei di essere i portatori del corona virus. L’estrema destra americana è scesa in piazza a fine aprile negli stati americani governati dai democratici per manifestare contro le restrizioni adottate per fermare la pandemia. E ancora una volta hanno trovato negli ebrei il loro principale bersaglio. È successo in Minnesota e in Illinois con attacchi frontali alla governatrice Gretchen Whitmar e al governatore J.B. Pritzker di origini ebraiche. Ma situazioni analoghe si sonno verificate anche in Wisconsin, Pennsylvania e Virginia.

Organizzazioni ebraiche come la JCPA (Jewish Council for Public Affairs) o l’Anti-Defamation League hanno subito fatto sentire la loro protesta, ma la prima reazione di Trump con uno dei suoi soliti tweet non è stata incoraggiante: “Questa è bravissima gente, ma sono arrabbiati. Li vedremo, gli parleremo, faremo un patto”. Poi a correggere il tiro ci ha pensato Elan Carr, inviato speciale del Dipartimento di Stato per la lotta all’antisemitismo: “Il mio ufficio sta rilevando nel mondo, soprattutto nei social media, uno tsunami di antisemitismo legato alla pandemia e alla crisi economica” ha detto.
Contro il virus delle teorie cospirative non è mai stato trovato un vero e proprio vaccino. E anche oggi al tempo del Covid-19 questo virus ha cominciato a diffondersi rimettendo nel mirino gli ebrei come da tradizione e non solo negli Usa. Ne parla il Centro Wiesenthal con un saggio specifico curato da Harold Brackman. Agli ebrei e Israele vengono attribuiti sia la colpa di aver creato il Covid-19, sia quella di volerlo sfruttare per propri fini o economici o politici. Le fonti delle accuse sono gli ambienti dell’estrema destra e del fanatismo islamico. Diversi sono gli episodi enumerati dal Centro Wiesenthal. Tra questi: l’Iran che accusa Usa e Israele di voler lanciare una guerra mondiale batteriologica, la tv irachena Al-Ayam che attribuisce ai Rothschild la responsabilità del virus così come lo sarebbero stati delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il gruppo di ricerca Louis Farrakhan che ipotizza che Israele abbia inventato il virus per poi fare i soldi con il vaccino. Non mancano, come riporta la CNN, le inevitabili accuse a Soros lanciate da Michael Caputo, attuale portavoce del Dipartimento della Salute americano, che prima della sua nomina aveva affermato che l’agenda politica di Soros richiede una pandemia. Anche il professor Yehuda Bauer sulle colonne del quotidiano Haaretz ha lanciato l’allarme per un antisemitismo che si nutre sempre degli stessi stereotipi e fa l’esempio di Assad al-Azzouni, un noto scrittore giordano, secondo il quale il Corona virus può essere solo il prodotto dell’odio che gli ebrei spargono nel mondo e una ricompensa a Trump per aiutarlo a farsi rieleggere. Le calunnie antisemite non fanno alcuna differenza tra comunità ebraiche della diaspora e Stato d’Israele. In questo contesto antisemitismo, antisionismo e anti-israelianismo si sovrappongono e affondano le loro radici in un odio millenario mai sopito. Tuttavia nella vasta casistica del fenomeno dell’antisemitismo c’è chi fa dei netti distinguo tra l’odio verso l’ebreo e quello verso il sionista. La definizione di quest’ultimo termine si presta a diverse interpretazioni soprattutto se disgiunte dal suo autentico significato storico.
Per chiarire i termini della questione non rimane che analizzarla su due piani differenti: quello storico e quello legato invece all’attualità dello Stato d’Israele, vittima di una crisi politico-ideologica senza precedenti nella sua pur breve e intensa storia.
Sappiamo quanto sia ancora forte oggi in Europa la memoria della Shoah e quanto questa susciti sentimenti positivi e negativi nello stesso tempo e quanto spessa essa si leghi a Israele. Così se una svastica accompagna su un muro il termine Juden e invece in un altro il termine Israele non possiamo fare a meno di pensare che si tratti di manifestazioni di antisemitismo in entrambi i casi e che le radici di questi episodi siano di fatto le stesse: un odio profondo verso gli ebrei come individui e come comunità collettiva.
Per sfuggire a questo odio non sono bastate nella storia assimilazione, isolamento, emigrazione, integrazione. Poi alla fine del ‘900 in seno agli ebrei europei si è fatta strada l’idea di dare una definizione nazionale dell’ebraismo, che superasse la tradizione e la religione, collanti secolari dell’identità ebraica. Quest’idea ispirata anche dal Risorgimento Italiano prese il nome di sionismo e si concretizzò in un movimento politico sancito dal primo congresso sionista convocato a Basilea dal 29 al 31 agosto del 1897. Il progetto di uno Stato ebraico era la possibilità di offrire agli ebrei, religiosi e atei, un contesto nel quale poter essere padroni del proprio destino. Alla domanda sul significato del sionismo il filosofo Yeshayau Leibowitz soleva sempre rispondere: “Gli ebrei hanno costituito lo stato d’Israele perché stufi di essere governati da altri”. Questa legittima aspirazione nazionale, riconosciuta sul piano internazionale prima dalla Dichiarazione Balfour del 1917 e poi trent’anni dopo da una risoluzione dell’ONU, è diventata bersaglio di una nuova forma di antisemitismo: l’antisionismo, cioè la negazione al popolo ebraico del diritto di autodeterminarsi. E si è trattato di uno sviluppo simultaneo. Il “complotto sionista” è diventato sinonimo di “complotto giudaico”: uno Stato ebraico pensato non per autodeterminarsi, ma per governare il mondo come avevano raccontato nel 1903 I Protocolli dei Savi di Sion e successivamente anche Hitler nel Mein Kampf, che attribuì agli ebrei anche la colpa del bolscevismo.
Successivamente i regimi comunisti dell’Est europeo nel dopoguerra perseguitarono i propri cittadini ebrei accusandoli di sionismo per emarginarli non solo quando manifestavano la volontà di emigrare in Israele. Definire un ebreo sionista bastava per poterlo perseguitare pensando di neutralizzare così l’accusa di antisemitismo.
Ai denigratori del sionismo si aggiunse pure l’ONU, che pure aveva fatto nascere lo Stato d’Israele. Avvenne il 10 novembre 1975 con la risoluzione ONU che definì il sionismo «una forma di razzismo e di discriminazione razziale»: un tentativo per delegittimare lo stato d’Israele. Questa risoluzione fu poi ritirata nel 1991 prima della conferenza di Madrid sul Medio Oriente.
Antisionista per principio è stato a lungo anche il mondo cattolico, tanto che solo nel dicembre 1993 il Vaticano riconobbe lo Stato d’Israele.
Nel tempo, e oggi sempre di più, l’esercitazione del diritto di autodeterminazione è diventato la garanzia della continuità dell’esistenza ebraica. Oggi, infatti, nel mondo quasi il 50% degli ebrei, che si riconoscono come tali, risiede in Israele. Il suo sviluppo economico e demografico è stato tale che oggi pare davvero un’assurdità che esista ancora chi ne metta in dubbio l’esistenza. Come afferma lo storico ebreo francese Georges Bensoussan (Una città 11/2004): “Il sionismo è una rivoluzione intellettuale e chi afferma che lo Stato d’Israele, oggigiorno, nell’Europa democratica e dei diritti dell’uomo, non ha più alcuna giustificazione, non ha capito nulla del sionismo. Non è la Shoah l’origine della nascita dello Stato d’Israele. Anche senza Shoah oggi esisterebbe lo stato israeliano. Anche in questo caso si parte da un’idea falsa degli ebrei, considerati tali solo dal punto di vista strettamente religioso. Si continua a non rendersi conto che gli ebrei, oltre a essere una religione, sono anche un popolo”.
Gli antisionisti vedono nella nascita d’Israele una sorta di “peccato originale”, la causa prima del conflitto arabo/palestinese/israeliano. Questa è stata a lungo la posizione anche di tutto il mondo arabo, che a lungo ha considerato Israele, uno stato coloniale fondato da europei estranei al Medio Oriente. L’odio verso Israele e il sionismo è stato traslato nelle moschee e ha assunto connotati religiosi sempre più estremi. I trattati di pace con Egitto e Giordania e gli accordi di Oslo non hanno contribuito, come ci si sarebbe potuto aspettare, a cambiare presso le popolazioni arabe la percezione negativa di Israele, del sionismo e degli ebrei in generale fatte salve alcune eccezioni come, per esempio, il Marocco e gli Emirati Arabi.
Che gli antisionisti non siano semplicemente coloro che criticano la politica dei governi israeliani ha cercato di spiegarlo sul quotidiano Haaretz Dan Miron, professore emerito di letteratura ebraica all’Università di Gerusalemme. Secondo Miron negli Usa chi dichiarandosi antisionista si oppone solo alla politica dei governi israeliani è definito con disprezzo “rosa”. “Alla base dell’antisionismo intellettuale al quale mi riferisco c’è, molto semplicemente, la richiesta di annullare l’esistenza dello Stato d’Israele”, dice il professore, che approva senza riserve la decisione del Parlamento Francese. “Macron e anche altri parlamenti europei hanno capito che l’antisionismo per principio non è semplicemente anti-israelianismo, ma è una delle forme dell’antisemitismo contemporaneo”.
La presa di posizione francese mira a togliere terreno sotto i piedi del movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) così come ha già fatto il parlamento tedesco e si è proposto di fare quello austriaco. I fautori del boicottaggio generalizzato d’Israele e dei suo cittadini non potranno più essere equiparati nei finanziamenti a organizzazioni no profit.
Se da una parte sembra inevitabile constatare che esista una sovrapposizione tra antisionismo e antisemitismo nell’opinione pubblica mondiale, dall’altra non si può ignorare come nello stesso mondo ebraico e israeliano il sionismo sia oggetto di negazione e strumentalizzazione. Ancora oggi i partiti religiosi ortodossi, Shas e Yaadut Hatorà, si considerano “non sionisti” così come ovviamente i partiti arabi uniti nella Reshimà Hameshutefet, orientata però ultimamente più verso la condivisione che non la contrapposizione. Di fatto oltre il 20% della Knesset (parlamento israeliano) è composto da non sionisti, da coloro cioè che non si riconoscono nel sionismo l’ideologia fondante dello Stato, che d’altra parte è fortemente strumentalizzata dal Likud e dalla galassia dei partiti di destra. Un esempio su tutti è la “Legge della Nazione”, che ribadisce l’esclusività ebraica nell’identità dello Stato d’Israele, peraltro già definita dalla Dichiarazione d’Indipendenza. Il testo di quest’ultima sancisce da una parte che “Lo Stato d’Israele sarà aperto all’immigrazione di ebrei da tutti i Paesi della loro dispersione” e dall’altra che “Lo Stato promuoverà lo sviluppo del Paese per il bene di tutti i suoi abitanti; si baserà sui precetti della libertà, della giustizia e della pace insegnata dal Profeti ebraici; rispetterà la piena uguaglianza sociale e politica di tutti i suoi cittadini, senza distinzione di razza, credo o sesso”. Uno Stato ebraico e democratico come ha sempre cercato di essere dalla sua fondazione. Ma oggi sembra che “ebraico e democratico” siano due definizioni sempre più difficili da tenere insieme tanto che invece di essere complementari stanno diventando sempre più alternative – e questo lo si deve soprattutto alla persistente occupazione dei territori conquistati dall’esercito israeliano nel 1967 e dove vivono tre milioni di palestinesi e 700mila ebrei israeliani. La soluzione due Stati per due popoli, oggi lontana, prevede uno Stato ebraico e uno Stato palestinese, ma se lo Stato diventasse definitivamente unico non potrebbe che essere democratico ed ebraico/palestinese. Il disegno del sionismo originario sarebbe stravolto e a condurre a questo risultato sarebbe proprio la destra nazionalista israeliana. Oggi dunque essere sionista o filosionista significa sempre più schierarsi contro la politica di Netanyahu e contro l’annessione dei territori, che potrebbe a breve diventare in parte realtà con l’appoggio di Donald Trump e del nuovo alleato Benny Ganz.
Schierarsi contro il populismo e il nazionalismo israeliano non significa essere antisionisti né tanto meno antisemiti, ma esattamente il contrario. E non è un caso che la destra nazionalista israeliana con Netanyahu in prima fila abbia interesse a definire antisemita chiunque critichi la loro ideologia e contemporaneamente chiuda gli occhi di fronte al risorgente antisemitismo di regimi populisti come quello di Viktor Orban in Ungheria o Jair Bolsonaro in Brasile.
Essere filoisraeliani e antisemiti nello stesso tempo è la loro paradossale strategia. E ad assecondarla c’è proprio Netanyahu anch’esso populista e nemico del sistema democratico.
Eppure se c’è una strategia perdente per il popolo ebraico è proprio quella di allontanarsi dall’idea che l’antisemitismo potrà essere limitato solo da chi rimane fedele ai valori democratici universali che difendono la libertà e l’identità di tutti allo stesso modo.
Analisi di Gabriele Eschenazi, giornalista




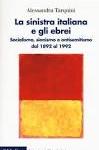
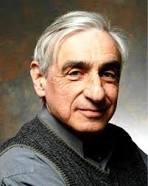



-kbkE-U3160890998995a5D-140x180@Corriere-Web-Sezioni.JPG?v=202001112050)